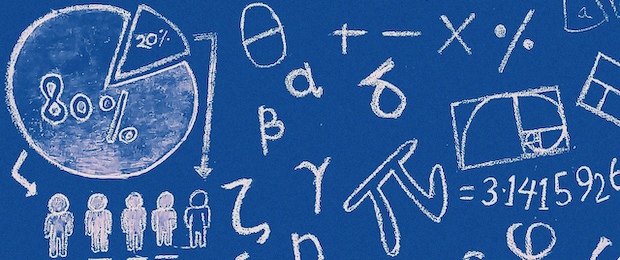Abbandoni scolastici: non solo orientamento ma anche formazione per il lavoro
Per evitare gli abbandoni scolastici non basta un miglior orientamento ma serve anche migliorare qualità e percezione della nostra formazione per il lavoro: garantire maggiore dignità ai percorsi professionalizzanti la chiave per riorientare le scelte di ragazzi e famiglie
L’Italia risulta al terzultimo posto della graduatoria internazionale degli Early School Leavers, gli studenti che abbandonano precocemente la scuola. Dopo un fuoco di paglia giornalistico destinato a spegnersi nell’arco di un mattino, l’unica ma non irrilevante conseguenza ne è l’iniziativa del ministro Valditara sulla figura dell’orientatore, iniziativa positiva soprattutto perché inizia ad articolare la figura docente in modo abbastanza appetibile (soldi ma soprattutto punteggi), anche se certo non una carriera. Del resto, a quanto pare, affrontare di petto la costituzione di una carriera si è rivelato suicida nei decenni passati per la ostilità dei sindacati e l’inerzia degli eventualmente interessati.
L’analisi delle cause di tale abbandono precoce ha fin qui preso due indirizzi: una scuola troppo dura che boccia e/o un orientamento sbagliato?
Una scuola troppo dura? Le analisi realizzate sugli effetti di COVID-19 evidenziano che nel 2020, quando per effetto delle disposizioni generali sostanzialmente tutti gli allievi sono stati promossi, gli abbandoni sono diminuiti. In effetti, le valutazioni internazionali da almeno due decenni dimostrano che la bocciatura nella maggioranza dei casi non serve ad aumentare il livello degli apprendimenti e, perciò, neppure la civilizzazione e l'occupabilità. Quando PISA (Program for International Student Assessment), dovendo campionare tutti i quindicenni, andava cercando i ripetenti anche in terza media, questi erano il gruppo con i risultati più bassi: una constatazione anticipata nei decenni precedenti anche da ricerche meno estese nei numeri e nell'ampiezza dei Paesi coinvolti. Questa è stata la ragione per cui molti Paesi hanno tendenzialmente abbandonato l’uso della bocciatura: il gioco non vale la candela, cioè le maggiori spese che il sistema della bocciatura comporta non generano un incremento degli apprendimenti significativo. In Italia non c’è stata nessuna decisione istituzionale, ma uno slittamento silenzioso verso un incremento delle promozioni. Però, contrariamente a quanto pensano nel nostro Paese i nemici dei voti e dell’Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di Istruzione e Formazione), i favorevoli a un uso esclusivo dell'autovalutazione o della valutazione fra pari, non si tratta di un felice approdo nel Paese dei Balocchi. Tutti alla meta negli altri paesi, ma con maglie differenti distribuite ai cancelli di uscita attraverso esami high stakes (con alta posta in gioco), come in Gran Bretagna, o punteggio delle prove in uscita parzialmente determinato da prove standardizzate esterne come in Germania. Oppure esami, sempre high stakes, per l’accesso all’università.
Che il problema non sia principalmente quello delle bocciature lo suggeriscono peraltro i dati Invalsi su quella che viene chiamata dispersione implicita. Dispersione implicita è un bell’eufemismo per dire che vengono promossi fino a quel traguardo molti studenti che non raggiungono i livelli minimi attesi in competenze di base come la lingua e la matematica, definite su una scala rapportata ai parametri internazionale, quelli che una percentuale più alta di coetanei di altri Paesi raggiunge. Dunque forse non si boccia troppo, anche alla maturità che promuove la quasi totalità dei candidati, premiando con i punteggi soprattutto quelli del Sud che nel complesso risultano non certo brillanti nelle prove Invalsi.
Un orientamento inadeguato? L’iniziativa del Ministero sulla figura dell’orientatore mira a permettere un orientamento più professionale da parte delle scuole, che dovrebbero scoprire fin dall’inizio le caratteristiche dell’allievo e valorizzarne ed accompagnarne le aspirazioni e le caratteristiche. Si tratta di un servizio importante che le società ricche possono permettersi a vantaggio sia della loro prosperità generale che di quella dei loro membri, un servizio che gli esseri umani si sono sempre procurati da soli, probabilmente con molti sprechi ed errori. Ma l’idea che l’orientamento – o meglio il mancato orientamento - delle scuole sia la causa principale della dispersione è tutta da discutere.
Diamo per appurato che il consiglio orientativo viene gestito in modo poco professionale, cioè non è il frutto di riflessioni significative da parte della collegialità dei docenti. Ma le rilevazioni che il Servizio Nazionale di Valutazione delle scuole ha effettuato sia attraverso i RAV (Rapporti di Autovalutazione, una sorta di self-check che le scuole da qualche anno debbono effettuare) che attraverso visite esterne, rivelano che le famiglie non necessariamente lo seguono. Infatti, tra i dati disponibili nei RAV, c’è quello della percentuale di allievi che segue il consiglio orientativo della scuola: le aggregazioni a livello nazionale effettuate ci dicono che si ferma al 60%. Le famiglie in realtà tendono a scegliere sulla base di tendenze generali della società e molto meno affidandosi al parere dei professori. Si tratta di un aspetto della crescente consapevolezza di sé - più o meno fondata - generata dall’uscita dalla povertà, dall’uso dei social e prima dei mezzi di comunicazione di massa etc.
E, in proposito, sembra consolidarsi una tendenza non solo italiana, ma un po’ di tutto l’Occidente, per cui uno degli aspetti del miglioramento delle condizioni di vita delle masse è l’abbandono della formazione per il lavoro per i figli. Oltre che della formazione nel campo tecnico-scientifico soprattutto a livello terziario, dove è più chiaramente riscontrabile. Fanno parziale eccezione gli abitanti dell’Europa Centrale a partire dalla Germania: Beruf protestante (senso della professione come dovere morale) e Impero austroungarico? Scuola politecnica del periodo comunista? L’Italia è un eccezionale terreno di coltura di questa tendenza, in forza della sua tradizione culturale, cui ha peraltro dato una buona mano la deindustrializzazione recente. Nel nostro Paese tale tendenza, che considera la formazione generalista (liceale?) come un consumo ostensivo, porta ampi settori di ceti piccolo-borghesi ad abbandonare gli istituti tecnici e professionali a favore dei licei “leggeri”, primo fra tutti quello delle scienze umane.
La formazione per il lavoro non gode di prestigio, soprattutto nelle regioni del Sud, e i ceti di basso livello economico-sociale – che sono quelli che danno il maggior numero di reclute agli Early School Leavers- non vi trovano un approdo formativo. Il loro posto negli ultimi decenni viene peraltro preso dai giovani immigrati, che al Nord, dove si fermano in percentuali significative anche come famiglie, hanno preso d’assalto la formazione professionale come primo livello di formazione e di ascensore sociale e stanno avviandosi anche verso livelli di istruzione ulteriori per coloro che possono, sia come capacità individuali che come livello economico-sociale.
Veder dunque l’abbandono scolastico come causato dalla durezza della scuola o da sbagli nella scelta delle scuole potrebbe essere molto riduttivo. I casi di creativi che volevano fare il liceo artistico e invece sono iscritti d’ufficio dai genitori alla ragioneria sono storie al massimo da anni Settanta. La realtà potrebbe essere che allievi ed allieve che abbandonano soprattutto perché hanno vocazioni preferenziali verso l’operatività devono poter trovare una approdo dignitoso e rispettato nella formazione per il lavoro. Senza incappare nella valanga di formazione generalista di cui è stata inzeppata - con ottime intenzioni - la stessa formazione professionale statale e che probabilmente è la prima ragione di abbandono.
Si tende poi a vedere l’abbandono come un indicatore di degrado sociale. Ma non sempre è così. Comunità coese dal punto di vista dei costumi e che offrono sbocchi economici e di stili di vita accettabili tendono a non incentivare la prosecuzione negli studi da parte dei giovani, anche perché tale prosecuzione viene vissuta come allontanamento dal gruppo che offre un contesto certo e appagante. Conta la tendenza a rimanere nel gruppo antropologico di appartenenza, fonte di serenità e di calore, il corrispondente timore di affrontare contesti potenzialmente frustranti e ostili, l’attrazione di una vita fatta sì di lavoro (spesso meno frustrante di una fatta di studio), ma anche di immediata soddisfazione di bisogni di autoespressione e di piaceri. In epoca giovanile si tratta di consumi ostentativi quali moto, vestiti etc, ma anche di libertà sessuale, consumi più agevoli di alcool e così via, per la disponibilità economica e l'autonomia personale. Questi fattori di permanenza nelle classi sociali di appartenenza e perciò di non prosecuzione degli studi sono ovviamente più forti ora che, diversamente dal passato, tale permanenza garantisce non solo la sopravvivenza materiale, ma anche un livello di vita e consumi del tutto accettabile, se non addirittura nell’immediato superiore - a livello della fruizione individuale - a quello di chi prosegue gli studi. A questo negli ultimi anni si aggiunge la perdita di prestigio delle cosiddette élite a livello dei ceti popolari che si esprime nella vita politica e sociale, anche grazie alla diffusione dei social media che vicariano funzioni di informazione e valutazione prima ricoperte dai ceti diffusi di piccola intellettualità, classica meta di studi generalisti a suo tempo molto appetiti.
I vantaggi di studi prolungati anche a livello della vita personale che vengono sottolineati dalle recenti ricerche si proiettano avanti nel tempo e non sono di immediata evidenza in età giovanile. Cosi come non è di immediata evidenza la necessità di acquisire livelli di alfabetizzazione accettabili per rimanere a livelli di vita dignitosi, di qui a qualche decennio. E qui, naturalmente, si parla di chi va in qualche forma a lavorare, non dei NEET – chi non studia né lavora - cui le famiglie hanno risolto il problema. Ma questo è un altro capitolo.
In definitiva, non basta la scuola, ci vuole l’impegno di tutta la società per affrontare il problema degli Early School Leavers italiani e un anello importante potrebbe essere valorizzare la formazione per il lavoro.
L'istituzione degli ITS potrebbe cominciare a dare una mano, perché la presenza di un livello alto di formazione darebbe maggiore dignità a tutto il percorso e perciò aiuterebbe a riorientare le scelte delle famiglie. Da notarsi peraltro che, quando si dice che in Italia la percentuale dei laureati si aggira intorno al 30% o poco più a fronte del 40% dell’Europa, si trascura di ricordare che nei conti del terziario europeo si computano i corsi terziari professionalizzanti, come i BTS nella stessa latina Francia. E da noi, invecem le università sono ancora ferme nella difesa delle loro fallimentari lauree cosiddette professionali.
Tiziana Pedrizzi per la Fondazione Anna Kuliscioff
9/5/2023