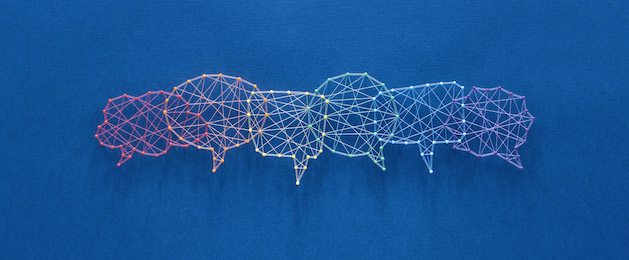Formazione, competenze e risorse per la scuola: quale la situazione italiana?
I risultati dell'indagine OCSE sulle competenze degli adulti hanno di recente infervorato il dibattito sulle scarse capacità linguistiche, matematiche e di problem solving degli italiani: al netto di allarmismi eccessivi, un'occasione per riflettere sull'efficacia del sistema di istruzione e formazione del nostro Paese
Nelle ultime settimane si è tornati a discutere con vivacità del sistema educativo italiano e delle (poche) risorse destinate non solo all’istruzione scolastica ma anche, successivamente, ad aggiornamento e formazione di quanti sono già in età da lavoro. A fare da detonatore i risultati dell’indagine OCSE sulle competenze degli adulti, svolta in 31 Paesi ed economie su un campione di età compresa tra i 16 e i 65 anni: indagine che vede gli italiani seriamente in affanno in competenze di base sia ai fini professionali sia, più in generale, per orientarsi con consapevolezza all’interno di scenari socio-economici e politici complessi come quelli che stiamo vivendo. L’Italia registra infatti risultati al di sotto della media in tutti e tre principali ambiti di analisi e monitoraggio, vale a dire literacy (capacità di lettura e comprensione di testi scritti), numeracy (comprensione e utilizzo di informazioni matematiche e numeriche) e problem solving (capacità di raggiungere il proprio obiettivo in una situazione dinamica in cui la soluzione non è immediatamente disponibile).
Figura 1 – Percentuale di adulti per livelli di competenza: Italia e media OCSE a confronto
Fonte: Indagine OCSE sulle competenze degli adulti 2023
Un’apparente débâcle che sembrerebbe oltretutto partire da lontano se si considera che conclusioni simili erano state registrate nel 2012, anno in cui era stata condotta l’indagine precedente: in oltre dieci anni, il nostro Paese non è riuscito a cucire il gap, tanto che resta ampia la distanza da colmare per raggiungere i risultati medi OCSE.
I risultati di dettaglio dell’indagine OCSE
In Italia, gli adulti di età compresa tra i 16 e i 65 anni hanno ottenuto, mediamente, 245 punti in literacy, 244 in numeracy e 231 punti in adaptive problem solving. Nel dettaglio, per quanto riguarda la capacità di comprendere testi scritti, il 35% dei nostri connazionali ha ottenuto un punteggio pari o inferiore al livello 1, il che significa che più di 1 italiano su 3 si limita a comprendere frasi brevi e semplici, mostrando difficoltà già davanti a testi di lunghezza modesta. La media OCSE è del 26%, tanto che a far peggio dell’Italia sono solamente Israele, Lituania, Polonia, Portogallo e Cile. All’estremità opposta solo il 5% del campione: solo 5 italiani su 100 – 12 su 100 la media di tutti i 31 Paesi indagati – sono cioè in grado di comprendere in profondità testi lunghi e articolati.
Non propriamente positivo neppure il posizionamento relativo alle competenze numeriche, che ci vede quartultimi, seguiti da Polonia, Portogallo e Cile. Il 35% degli adulti del Belpaese, a fronte del 25% della media OCSE, è in grado di risolvere solo calcoli piuttosto semplici, come quelli necessari a gestire il denaro nella quotidianità, ma manifesta viceversa difficoltà quando si tratta di cimentarsi con compiti che richiedono più passaggi (come, ad esempio, la risoluzione di una proporzione). In questo caso, i cosiddetti high performer, vale a dire coloro che raggiungono il livello 4 o 5, rappresentano il 6% del campione, meno della metà della media OCSE (14%). Si tratta cioè di soggetti, conti alla mano molto pochi, capaci di calcolare tassi e rapporti, interpretare grafici complessi o, ancora, valutare criticamente informazioni statistiche.
Ultima competenza fondamentale per gestire la complessità della vita moderna è quindi il problem solving, ambito nel quale è addirittura pari al 46% la percentuale di quanti ottengono un punteggio pari o inferiore al livello più basso. Un dato ancora più sorprendente se si considera che la media è del 29% e che solo l’1% degli adulti italiani (a fronte del 5% della media complessiva) ha ottenuto un punteggio di livello 4. Mentre cioè la metà della popolazione ha difficoltà nel risolvere problemi che richiedono più passaggi o implicano il monitoraggio di più variabili, riuscendo a risolvere senza troppe criticità solo quelli più semplici, solo 1 italiano su 100 mostra spiccate capacità di adattamento a cambiamenti inaspettati. Con questi presupposti, non sorprende che per questa competenza solo Lituania, Polonia e Cile facciano peggio del nostro Paese.
Le competenze degli adulti italiani: quanti divari!
A pesare sui risultati complessivi del Paese ampi divari interni, determinati principalmente da territorio, età, livello di istruzione e genere. Ad esempio, i residenti di Nord e Centro d’Italia riescono spesso a raggiungere punteggi di competenza pari a quelli medi, al contrario di quanto accade nel Mezzogiorno dove i valori sono significativamente inferiori sia alla media italiana che a quella OCSE. Nelle capacità di comprensione e utilizzo di informazioni matematiche e numeriche le donne – che scontano verosimilmente retaggi culturali che tendono ad allontanarle dalle cosiddette discipline STEM - restano poi piuttosto distanti dagli uomini, con ben 7 punti di differenza; pressoché inesistenti, invece, le differenze di genere in literacy e problem solving.
Benché non inaspettato, merita tra gli altri particolare approfondimento il gap anagrafico: la fascia 55-65 mostra, infatti, in tutti gli ambiti livelli di competenza inferiori rispetto a quella 25-34. Una forbice in parte spiegata da fisiologici fenomeni di invecchiamento anche cognitivo (anche in altri Paesi le competenze tendono a cambiare con l’età e, in particolare, a calare nelle fasce anagrafiche più avanzate) e in altra dovuta alla maggiore vicinanza dei più giovani all’istruzione scolastica, che parrebbe oltretutto migliorata generazione dopo generazione sia in termini di quantità che di qualità. D’altro canto, in tutte le economie monitorate, livelli di istruzione più elevati sono associati a maggiori competenze: in Italia, gli adulti in possesso di un titolo di istruzione terziaria registrano una media di circa 19 punti più alta rispetto a quelli con un titolo di scuola superiore secondaria ma la forbice complessiva dell’area OCSE è addirittura pari a 33 punti; il gap tra l’istruzione secondaria superiore e quella inferiore è invece di 35 punti nel nostro Paese e di 43 nella media OCSE. Percentuali da leggere e interpretare, come ricorda INAPP, alla luce del fatto che in Italia solo il 20% delle persone tra 25 e 65 anni possiede un livello di istruzione pari o superiore alla laurea, mentre circa il 38% ha un titolo di studio inferiore al diploma.
Pur tenendo conto delle storture implicite in questo tipo di indagini che, a cominciare dalla modalità di somministrazione, quella del testing,tendono forse a favorire quei Paesi che adottano le stesse tecniche in ambito scolastico (e non è questo il nostro caso), i risultati della ricerca offrono quindi lo spunto anche per qualche considerazione sulla qualità dei sistemi di istruzione adottati in alcune delle principali economie mondiali, andando di fatto a integrare valutazioni (si pensi all’INVALSI) realizzate direttamente a scuola. Utile in questo senso guardare allora ai punteggi ottenuti dai più giovani, vale a dire da coloro che stanno concludendo o hanno da poco concluso la loro carriera scolastica: in Italia, il campione di età compresa tra i 16 e 24 anni ha ottenuto 263 punti in literacy, 259 in numeracy e 245 punti nel problem solving adattativo. Anche qui, il nostro Paese si posiziona al di sotto della media in tutti gli ambiti ma indicatori diversi arrivano dall’indagine PISA 2022, con focus proprio sul rendimento degli studenti italiani: se in matematica il punteggio è in linea con quello dei Paesi di area OCSE che hanno partecipato, in lettura i nostri giovani fanno addirittura meglio della media, salvo poi fare peggio nelle scienze.
Investire in istruzione e formazione a favore del futuro del Paese
Volendo sintetizzare, si potrebbe dire che il bagaglio di competenze iniziali degli italiani è discreto, per quanto non eccellente, ma il nostro Paese – tra quelli più esposti alla transizione demografica che sta investendo tutte le società occidentali – paga una notevole perdita di competenze all’avanzare dell’età. Pur con tutte le cautele del caso e trascurando volutamente in questa sede il fondamentale tema dell’invecchiamento attivo, dalla ricerca OCSE si possono quindi trarre almeno due importanti conclusioni.
La prima riguarda il ruolo essenziale dell’investimento in istruzione nel coltivare e accrescere le competenze dei cittadini. Competenze a loro volta fondamentali per partecipare con successo all’economia e alla società contemporanea, oltre che per gestire – anche in un contesto professionale – i processi legati all’innovazione. Eppure, sempre l’OCSE ci ricorda che l’Italia destina a istruzione, ricerca e sviluppo solo il 4% del proprio Prodotto Interno Lordo: il dato è inferiore alla media, pari al 4,9% del PIL, ed è rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo decennio tanto in Italia quanto altrove, seppur con differenze anche piuttosto ampie da un Paese all’altro. Nel caso dell’Italia significativo, tuttavia, rimarcare come la spesa tenda a variare in modo sostanziale in base al livello di istruzione considerato, con maggiore riguardo nei confronti dei livelli meno avanzati: se la quota di spesa dedicata all’istruzione obbligatoria è in linea con quella dell’area OCSE, lo stesso non si può dire per quella terziaria dove il gap è di circa 8 punti percentuali. Detto altrimenti, gli investimenti dell’Italia non sono solo ridotti ma anche distribuiti in modo disomogeneo tra i diversi gradi di istruzione, penalizzando proprio quella formazione universitaria che, si è visto, tende a garantire il consolidamento e il mantenimento di un buon livello di competenze linguistiche, numeriche e di problem solving anche nel corso della vita adulta.
Considerazione, quest’ultima, che apre le porte alla seconda conclusione: quale è il legame tra le competenze acquisite dai cittadini e la loro successiva occupabilità? O, più in generale, sull’economia e sulla società italiana? Premessa indispensabile a farsi è che se è vero che gli adulti con competenze più elevate sono quelli “più istruiti”, lo è altrettanto che, secondo l’OCSE, «i benefici di possedere competenze più elevate si estendono oltre le opportunità associate semplicemente alle qualificazioni attinenti ai percorsi di istruzione formali». Innanzitutto, fatto prevedibile, a competenze più elevate si associano generalmente migliori opportunità professionali: emblematico il caso della numeracy, ambito per il quale prestazioni elevate spesso equivalgono non solo a una più alta probabilità di partecipazione alla forza lavoro ma anche a un incremento statisticamente significativo delle retribuzioni. In secondo luogo, fatto forse meno scontato ma comunque non trascurabile, dalla ricerca emerge come le competenze siano strettamente correlate anche a benessere individuale e impegno civico dei cittadini. Gli adulti che raggiungono i più elevati livelli di competenza dichiarano cioè livelli di soddisfazione della propria salute e della propria vita maggiori, mentre quelli con competenze ridotte manifestano insoddisfazione per il loro ruolo nella società, sentendosi anche esclusi dai processi politici del proprio Paese.
Ora, sarebbe ingenuo pensare alla scuola come all’unico attore e fattore coinvolto nella crescita cognitiva e culturale degli individui: ciò premesso, la formazione scolastica è e resta però un tassello fondamentale nella costruzione del futuro di un Paese. Viene allora da chiedersi se l’Italia stia facendo abbastanza per gettare delle fondamenta solide: le risorse stanziate basteranno per modernizzare l’istruzione? Per progettare percorsi formativi che sappiano rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, attenuando i casi di mismatching e favorendo i processi di innovazione? Per garantire un corpo docente qualificato e aggiornato per tutte le materie e in tutte le regioni, lì dove l’età media degli insegnanti italiani è più elevata rispetto alla media dell’area OCSE? Per ridurre ulteriormente il numero dei propri NEET in un Paese nel quale si tocca il record di occupati con 24 milioni di lavoratori su 38 in età da lavoro? Verrebbe da dire di no e basta l’esempio del mismatch per farsi un’idea della necessità di agire con tempestività ed efficacia. In Italia, circa il 15% dei lavoratori è over-qualified (la media OCSE è del 23%) e un altro 18% è under-qualified (la media è del 9%), il che significa che il titolo di studio più elevato conseguito è superiore o inferiore al titolo normalmente richiesto per svolgere il proprio lavoro. Circa il 6% dei lavoratori dichiara poi che le competenze possedute sono inferiori a quelle richieste per svolgere il proprio lavoro, lamentando carenze soprattutto nelle capacità organizzative e/o di gestione dei progetti (30%) e nelle lingue straniere (29%), mentre il 40% si sente in una situazione di mismatch rispetto all’area di studio, perché l’ambito del titolo di studio conseguito non corrisponde a quello della professione svolta. Numeri che segnalano non solo un’inefficiente allocazione della nostra forza lavoro ma probabilmente anche titoli di studio (e competenze) incapaci di tenere il passo con i cambiamenti strutturali dell’economia.
E, più che sui risvolti sensazionalistici dell’ultima indagine del caso, è proprio sulle risposte concrete da fornire a queste domande che dovrebbe concentrarsi l’opinione pubblica. Perché fornire un’istruzione di qualità, equa, inclusiva e ricettiva nei confronti delle trasformazioni epocali in atto resta la migliore strategia per garantire maggiori opportunità professionali e di mobilità socio-economica ma anche per fare welfare, ben prima che situazioni emergenziali obblighino a intervenire con sussidi o misure assistenziali. E per investire nel Paese stesso e nel suo futuro, valorizzandone quanto più possibile il capitale umano.
Mara Guarino, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
30/12/2024