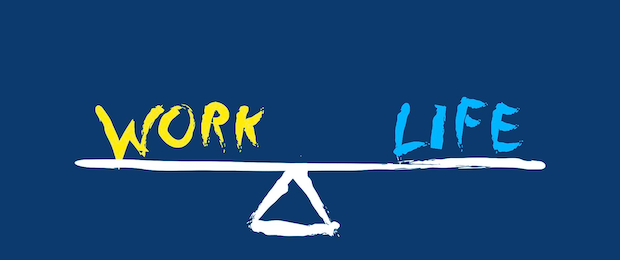Donne, natalità e conciliazione vita-lavoro: c'è ancora molto da fare
Per molte lavoratrici italiane la famiglia resta difficile da coniugare con la professione, tema di cui non si può non tenere conto quando si discute della bassa natalità del Paese. Ecco allora come servizi per l'infanzia e strumenti di conciliazione potrebbero favorire occupazione femminile e genitorialità
La pubblicazione delle Previsioni Istat relative a popolazione residente e famiglie ha di recente riacceso il dibattitto sulla bassa natalità nel nostro Paese, tanto che da qui al 2050 solo 1 famiglia su 5 sarà composta da una coppia con figli (oggi lo sono 3 su 10), mentre il 41,1% dei nuclei familiari sarà costituito da persone sole (oggi 36,8%). Tra i dati cui prestare maggiore attenzione quelli relativi al tasso di fecondità, nel 2024 sceso a 1,18 figli per donna ma previsto salire – nello scenario mediano dall’Istituto – fino a 1,46 nel 2080: un aumento dei livelli produttivi che dovrebbe far risalire le nascite fino a quota 401mila unità nel 2038 ma che, successivamente, non dovrebbe invece portare a un ulteriore incremento della natalità, in quanto contrastato da un progressivo calo delle donne in età feconda. Nel 2024 il numero delle donne con età compresa tra i 15-49 anni ammontava a 11,5 milioni ma, sempre in base allo scenario mediano, tale contingente dovrebbe contrarsi fino a 9,1 milioni nel 2050 e a 7,6 nel 2080.
Insomma, nel nostro Paese si vive sempre più a lungo, anche se non sempre in buona salute, ma si nasce meno, anche nel confronto con l’Europa: tutte tendenze che, proprio perché combinate tra loro, obbligano – al netto di facili allarmismi su culle vuote e pensioni future non pagate – a riflettere sul nostro sistema di protezione sociale. Se, da un lato, il progressivo invecchiamento della popolazione porta con sé indubbie opportunità, come quelle legate alla Silver Economy o più in generale al possibile ripensamento di un capitalismo ormai fin troppo sfrenato (a discapito della sostenibilità stessa del Pianeta), dall’altro sono evidenti le sfide da affrontare, come quelle della non autosufficienza in un contesto di probabile arretramento del welfare familiare. Una prospettiva ancora più grave in un Paese che finora si è solo scarsamente attrezzato per affrontare al meglio il nuovo corso della demografia.
E se è vero che la demografia dei prossimi anni è già scritta (anche ammessa un’improvvisa e improbabile inversione di tendenza, l’Italia sarebbe comunque ormai destinata ad affrontare il picco del suo invecchiamento intorno al 2045/2050), lo è altrettanto che qualche considerazione sulla natalità è comunque doverosa. Tanto più se si considera che, negli ultimi anni, non sono mancati provvedimenti a sostegno della genitorialità: misure in alcuni casi così recenti da richiedere ancora tempo per un’accurata valutazione sulla loro efficacia ma che sembrano comunque accumunate dalla tendenza a privilegiare l’erogazione di risorse e strumenti monetari rispetto all’efficientamento dall’offerta di servizi. Strada, quest’ultima, senza dubbio anche più lenta e difficoltosa da percorrere.
Il difficile work-life balance delle donne italiane: dimissioni e oneri di cura
Pur non certo esaustivo dell’intera questione e di tutte le sue implicazioni (molteplici in verità i fattori culturali e sociali che si intrecciano con quelli di natura economica sulla scelta individuale di avere o meno figli), uno dei nodi centrali per le famiglie, e in particolare, per le donne italiane è senza ombra di dubbio quello della conciliazione tra attività professionale e vita familiare.
Un tema - va detto - che di per sé non dovrebbe conoscere genere ma che, anche per retaggi storici, si tinge di “rosa” quando si guarda ai numeri: pur in costante miglioramento, l’occupazione femminile nel nostro Paese stenta a decollare, con gli ultimi dati diffusi da Eurostat che vedono l’Italia (53,1% nell’ultimo trimestre 2024) distante di oltre 10 punti percentuali dalla media europea (fissata, nello stesso periodo, al 66,3%). Le donne italiane non solo entrano o faticano a entrare nel mercato del lavoro e, seguendo un trend che riguarda anche la popolazione maschile, lo fanno in ritardo rispetto ai colleghi europei, il che sicuramente incide anche sull’età alla quale diventano madri (l’età media era di 32,5 anni, tra le più alte in UE al 2027), ma sono anche spesso coinvolte anche nel fenomeno del part-timeinvolontario (con percentuali persino doppie rispetto alla media europea) e più inclini alle dimissioni per motivazioni connesse alla gestione della genitorialità.
Secondo la Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (anni 2023 e 2024) a cura dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al 2024 sono state 41.406 le dimissioni volontarie convalidate a donne lavoratici nei primi 3 anni di vita del figlio, contro le 18.048 dei lavoratori di sesso maschile. Piuttosto costante nel tempo poi la predominanza tra i dimissionari di genitori di figli entro il primo anno di età: dato che, associato alla prevalenza femminile delle convalide rese sul totale, conferma come la fase più critica per restare nel mercato del lavoro siano i 12 mesi successivi all’arrivo del bambino o della bambina. Evidenza che trova conferma anche nelle motivazioni indicate al momento della richiesta di convalida. Delle 99.056 motivazioni indicate nel 2024, il 39,3% è concesso alla difficoltà di conciliazione con i figli per ragioni legate alla disponibilità di servizi, mentre il 25,9% indica comunque difficoltà connesse al lavoro (organizzazione del lavoro o scelte datoriali). Non solo, la percentuale relativa l’assenza di servizi sale al 47,5% tenendo conto delle sole convalide riguardanti donne lavoratrici; di contro, per i lavoratori padri, la ragione principale di recesso è il passaggio a un’altra azienda, citata nel 66,6% del 2024, a fronte del 21,1% registrato dalla “cura dei figli”. Uno sbilanciamento che riflette senza troppe sorprese quello legato agli oneri di cura, che vedono ancora oggi i nuclei familiari con prole dipendere dalla donna in assenza di supporto dalle famiglie di provenienza o da servizi di assistenza come baby-sitter e asili nido, spesso difficilmente accessibili e onerosi. Tutti costi, per forza di cose, solo parzialmente attenutati dalle misure monetarie a sostegno della genitorialità oggi previste dal welfare italiano.
Potenziare i servizi, in favore di occupazione e natalità
Se è vero che molte donne oggi scelgono consapevolmente, compiutamente e legittimamente di non essere madri, lo è altrettanto che il contesto non sembra però favorevole a quante vorrebbero invece percorrere il sentiero opposto. Ed è qui che dovrebbero concentrarsi gli sforzi della nostra classe politica. Chiaro innanzitutto come la leva economica, peraltro spesso attuata attraverso provvedimenti di natura transitoria e non strutturale, che quindi rischiano di aggravare i conti delle finanze pubbliche senza neppure avere il tempo di sortire effetti concreti, non possa (quantomeno da sola) considerarsi efficace.
Ancora di più se si tiene conto di ambiti altrettanto indispensabili ma al momento ancora del tutto insufficienti, come l’offerta di nidi e servizi integrativi per l’infanzia, con posti disponibili sia nelle strutture pubbliche che in quelle private pari per l’anno educativo 2022/2023 a 30 posti ogni 100 bambini residenti tra gli 0 e 2 anni e, dunque, un tasso di copertura ancora distante dal target UE di 45 posti per 100 bambini definito per il 2030 dai cosiddetti “obiettivi di Barcellona”. Pesanti poi i divari territoriali, con il Nord e il Centro in verità pressoché compatti al di sopra di quel 33% che rappresenta il livello minimo di copertura, ma “penalizzati” nella media nazionale da un Sud fermo a meno del 18%.
Eppure, proprio i dati sull’occupazione – più bassi nel Mezzogiorno o, ancora, più elevati in Europa proprio lì dove i servizi per l’infanzia sono più strutturati – sembrerebbero rimarcare l’esistenza di una chiara relazione tra la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l’estensione dei servizi per la prima infanzia. Che, come smart working e orari flessibili o agevolati non sono possono essere considerati la panacea di tutti i mali ma restano strumenti essenziali per creare un contesto socio-economico nel quale le famiglie non debbano vivere la scelta della genitorialità come oppositiva a quella di avere un impiego o costruirsi una carriera.
Mara Guarino, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
25/8/2025