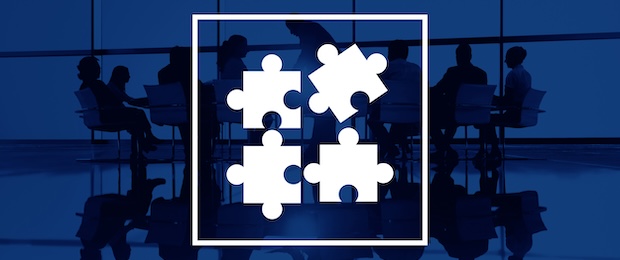Donne, lavoro e risparmio previdenziale: spunti per un futuro più consapevole
Gli ultimi dati COVIP confermano la modesta partecipazione delle donne alla previdenza complementare: salari e tassi di occupazione inferiori contribuiscono a spiegare il fenomeno, ma non bastano a restituirne una fotografia completa. Necessaria a elaborare possibili soluzioni che passano, ancora una volta, anche da una maggiore educazione finanziaria
Come conferma anche l’identikit dell’aderente tipo che è possibile tracciare a partire dai dati dell’ultima Relazione annuale COVIP, spesso le categorie più restie ad aderire a una forma pensionistica complementare sono quelle che avrebbero maggiori necessità di coperture integrative, e le donne non fanno purtroppo eccezione. Come sottolineato anche dal Presidente della Commissione di Vigilanza Mario Pepe, la composizione degli iscritti resta infatti sbilanciata a favore degli uomini.
Nel dettaglio, su 9.952.684 di aderenti alla previdenza complementare, alla fine del 2024, gli uomini erano il 61,6%, mentre le iscritte di sesso femminile rappresentavano solo il 38,4% del totale, percentuale purtroppo priva di grosse variazioni nel corso del tempo (erano il 38,3% della platea complessiva a fine 2020). Uno squilibrio meno accentuato nel caso delle forme di mercato ma particolarmente evidente del caso dei fondi pensione negoziali dove la presenza femminile scende addirittura al 27,6%. D’altro canto, se il disequilibrio tra i generi tende a trovare conferma anche tra le diverse fasce anagrafiche, con la sola eccezione delle classi di età più giovani che raccolgono soprattutto familiari a carico, è interessante allo stesso modo osservare l’analisi per condizione professionale: lo spaccato per genere sulla base della posizione lavorativa conferma infatti la prevalenza degli uomini sia per i dipendenti (il 63,4% dei 7,311 milioni di aderenti totali) sia per gli autonomi (il 66% su 1,205 milioni di iscritti). A discostarsi dalla media generale solo gli “altri iscritti” - categoria eterogenea nella quale ricadono soggetti fiscalmente a carico, aderenti che hanno perso i requisiti di partecipazione o, ancora, soggetti per i quali più semplicemente non si dispone di informazioni aggiornate – nella quale le donne (51,8%) sopravanzano, seppur di poco, gli uomini.
Figura 1 – Iscritti alle forme pensionistiche complementari per genere, età e tipologia di forma
Fonte: Relazione COVIP per l’anno 2024
La partecipazione femminile al mercato del lavoro e alla previdenza complementare
Un quadro che sembra portare a una prima, forse fin troppo ovvia, conclusione: la minore partecipazione femminile delle donne alla previdenza complementare è un riflesso diretto della loro minore partecipazione al mercato del lavoro. Guardando sempre al 2024, come puntualizza anche l’ultimo Rapporto annuale Istat, nonostante l’Italia abbia raggiunto il suo massimo storico con quasi 23,9 milioni di occupati, il nostro Paese presenta ancora tassi di partecipazione tra i più bassi d’Europa, soprattutto tra giovani e donne; categorie che, in particolar modo nel Mezzogiorno, contribuiscono a mantenere elevato il tasso di inattività nazionale. Alla fine dello scorso anno, nel dettaglio, l’Italia contava 23,932 milioni di lavoratori per un tasso di occupazione pari al 71,1% per gli uomini e del 53,3% per le donne, con un divario di genere che sfiorava dunque i 18 punti percentuali. Non solo, malgrado il trend comunque positivo vissuto dall’occupazione femminile negli ultimi anni, il tasso di inattività delle donne italiane era pari al 42,4%, con una distanza dal valore medio europeo del 13,1%.
Sarebbe tuttavia semplicistico guardare al solo mercato del lavoro, come del resto danno riprova anche i dati COVIP sui tassi di partecipazione rispetto all’occupazione. In particolare, in rapporto alle forze di lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione con almeno 15 anni di età), platea che conta 25,596 milioni di unità nella media del 2024, il tasso di partecipazione, considerando il numero di iscritti depurato degli individui minori di 15 anni, ammonta al 38,3%, scendendo tuttavia al 27,6% laddove si considerino i soli iscritti con versamenti nell’anno. Passando dal quadro generale a quello per genere, risulta ancora una volta evidente come gli uomini partecipino alle forme pensionistiche integrative più delle donne (41,3% contro 34,1%): una disparità netta e trasversale rispetto alla fascia di età nella forza lavoro con una forbice costante intorno ai 7 punti percentuali. Fanno eccezione le classi più giovani e soprattutto i minori, dove il divario si attenua più per scelte della famiglia di appartenenza che del singolo.
Insomma, è indubbiamente vero le donne aderiscono meno alla previdenza complementare anche perché lavorano meno degli uomini ma lo è altrettanto che la partecipazione femminile resta più bassa anche dopo il loro ingresso nelle forze lavoro. Un tema di quantità cui se ne associa anche uno di qualità: così come Istat conferma le maggiori difficoltà delle lavoratici in termini di disparità retributive, mobilità occupazionale e stabilità della propria condizione professionale (quasi un quarto delle donne sperimenterebbe forme di lavoro precario o part-time involontario), i dati COVIP testimoniano differenze di genere non solo sul versante delle adesioni ma anche su quello della contribuzione, con inevitabili ripercussioni sull’adeguatezza delle future prestazioni. A fronte di un contributo medio pro capite di 2.890 euro, gli uomini versano ai fondi pensione aperti, negoziali, preesistenti e PIP circa 3.080 euro, il 18,9% in più delle donne, “ferme” a quota 2.590 euro.
Figura 2 – Contributo medio per genere e classi di età
Fonte: Relazione COVIP per l’anno 2024
Un circolo vizioso che riflette quanto accade all’interno della previdenza obbligatoria dove, a dispetto dei luoghi comuni sulla materia, le donne scontano sì il peso di assegni pensionistici meno “generosi” di quelli maschili ma non per effetto di regole più penalizzanti nei loro confronti, quanto piuttosto per la maggiore difficoltà a maturare nastri contributivi lunghi e costanti.
La previdenza femminile: regole, importi e gender gap tra falsi miti e realtà
Premesso che l’età pensionabile per il pensionamento di vecchiaia è stata ormai da tempo uniformata per entrambi i sessi, l’ordinamento italiano riserva alla platea femminile alcune – piccole – agevolazioni. In particolare, se per quanto riguarda la pensione di vecchiaia – 67 anni di età e 20 di contributi o, in alternativa 71 anni di età e 5 di contributi – è previsto uno sconto di 4 mesi per ogni figlio avuto, fino a un massimo di 12 mesi, per le lavoratrici madri che ricadono nell’ambito del sistema di calcolo contributivo, leggermente più basso per tutte le donne è invece il requisito contributivo richiesto (a prescindere dall’età anagrafica) per il conseguimento della pensione anticipata. Fino al 2026 sono infatti richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Effettivamente su misura è invece come dice il nome stesso, Opzione Donna, i cui requisiti sono stati inaspriti negli ultimi anni: a ogni modo, attualmente, la misura consente il pensionamento anticipato per le lavoratrici con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 se autonome) che rientrino in alcune specifiche categorie individuate dalla legge, a condizione però di vedere il futuro assegno interamente ricalcolato con il metodo di calcolo contributivo. Un’opzione sperimentale al pari di APE sociale, che, a partire dall’1 gennaio 2018, prevede per le lavoratrici madri uno sconto nella maturazione della contribuzione utile pari 1 anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.
Difficile dunque parlare di regole particolarmente favorevoli, per quanto il quadro non sia certo roseo per le pensionate donne, ma non tanto per la difficoltà di accesso al pensionamento quanto piuttosto per gli importi maturati. L’ultimo Rapporto Itinerari Previdenziali conta infatti 16.230.157 di pensionati: di questi, il 51,6% è rappresentato da donne. D’altro canto, però, anche proprio per effetto della reversibilità, che vedono le donne beneficiarie nell’85,8% dei trattamenti, con quote della pensione diretta del dante causa variabili tra il 60% e il 30%, in base al reddito del superstite, pur a fronte del maggior numero di prestazioni erogato a soggetti femminili (il 54,7% del totale), le donne percepiscono solo il 42,9% dei 314,894 miliardi di euro pagati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per prestazioni IVS. Se si sommano le prestazioni previdenziali con quelle assistenziali e indennitarie (in totale 22.919.888 pensioni), il reddito pensionistico annuo delle donne ammonta a 18.291 euro mentre quello degli uomini a 24.671: le pensionate registrano un maggior numero di prestazioni pro capite – 1,5 a testa contro l’1,319 dei pensionati maschi – ma prevalgono soprattutto nel caso di prestazioni dall’importo modesto, come appunto le reversibilità o quelle prodotte da “contribuzione volontaria”. Tutte ragioni per quali beneficiano poi di un numero più consistente di misure di matrice assistenziale, come importi aggiuntivi, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, e così via.
Il che, da una parte, spiega come mai sarebbero particolarmente bisognose di coperture integrative e, dall’altra, pone in una luce nuova il tema del gender gap pensionistico. Affermare che le pensionate percepiscono prestazioni di importo inferiore agli uomini è sì corretto dal punto di vista formale ma parzialmente fuorviante da quello sostanziale: il sistema previdenziale italiano non fa che riflettere l’andamento del mercato del lavoro il quale, malgrado segni di lento e progressivo miglioramento, si caratterizza tuttora per tassi di occupazione e livelli retributivi poco favorevoli alle lavoratrici. Un work-life balance complicato, anche per resistenze storiche e culturali, complica di fatto lo sviluppo di contribuzioni di spessore e quindi la futura vita da pensionata.
Per un miglioramento della condizione femminile: dal lavoro al risparmio previdenziale consapevole
Di qui, la necessità di inquadrare la questione all’interno di una prospettiva più ampia: occorrono interventi che favoriscano avanzamento della condizione lavorativa delle donne, attraverso misure e servizi, come quelli all’infanzia o lo smart working, riducendo la discontinuità delle carriere femminili, ma anche iniziative di alfabetizzazione finanziaria e previdenziale, intendendo appunto per previdenza la propensione a guardare al futuro tutelandosi da rischi e incognite. I dati sui tassi di partecipazione evidenziati da COVIP possono del resto sì essere spiegati, almeno in parte, con condizioni professionali precarie e salari più bassi, che possono generare dubbi sulla capacità di riuscire a mantenere regolarmente un piano pensionistico integrativo, ma verosimilmente dipendono anche da una non totale consapevolezza dei benefici che potrebbero derivare dall’adesione. Soprattutto per una platea potenzialmente più vulnerabile al momento del pensionamento, a causa di posizioni lavorative flessibili e interruzioni contributive.
Mara Guarino, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
9/7/2025